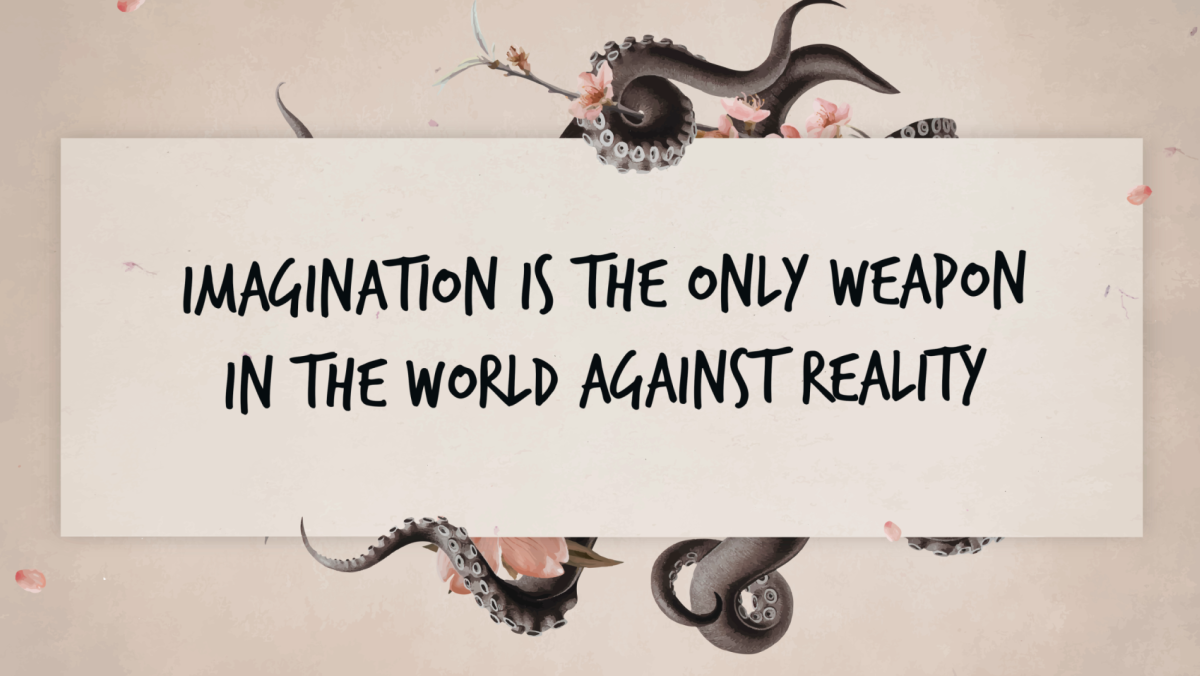In questo gennaio parecchio freddo mi sono imbarcata in un viaggio a Napoli. In un tempo storico che va dal dopoguerra agli anni settanta.
Napoli, simbolo, esempio vivo di città abbandonata dallo stato, in balia dei poteri illeciti.
Tra i vicoli incontriamo i figli dei sopravvissuti: Maria, Enzina, Totonno, Ciruzzo e Rosetta a cui si aggiungerà Lucio, in fuga dalle sue radici.
Tanti sono i modi in cui si può descrivere la condizione di sopravvissuti, raccontando fatti, eventi, conseguenze.
L’autrice in questo romanzo fa una scelta ben precisa, ci racconta l’esperienza della sopravvivenza attraverso le emozioni.
Spoglia i personaggi di ogni pudore e ce li presenta fragili e al contempo forti.
Non si limita a raccontarci ad esempio di Beppe che esce dall’ospedale per tornare a casa ma ci porta con lei davanti a quest’uomo che con fatica si stacca dall’abbraccio dei figli e della moglie e si avvicina a una donna con una bambina, la figlia di Mariuccio.
Si scusa Beppe, si scusa a nome della guerra e dei grandi interessi che l’hanno voluta, si scusa per non essere riuscito a riportare il padre ad una bimba ancora allattata al seno.
Si scusa con la voce strozzata in gola in un momento di inevitabile commozione.
Lui, Beppe, il postino sopravvissuto.
Molti i nomi illustri buttati con sapienza tra le pagine, nomi che appartengono tanto a Napoli, quanto al mondo intero.
Che hanno combattuto sul fronte della resilienza con le armi dell’arte e della cultura, con quel pizzico di follia tipica partenopea che amplifica le passioni e con esse gli sforzi per ottenerle.
I grandi uomini e le grandi donne di Napoli hanno la bellezza della città dentro e lo sguardo sempre attento verso i figli meno fortunati.
Non si girano dall’altra parte.
Puoi non amare quello scrittore, puoi non apprezzare quell’attore o quel cantante, ma non puoi non vedere quel senso di appartenenza di cui sono gli unici custodi e quando si danno al mondo lo fanno sempre col cuore aperto alla bellezza della loro terra.
Scorrono le pagine e con esse inevitabilmente scorrono gli anni, anni in cui poteri di ogni tipo hanno fatto il buono e il cattivo tempo della città e se ne discute a tavola con la famiglia, a Natale.
Parole che non rimangono lì ferme, ad aspettare.
Discorsi di un’Italia che stava scoprendo la lavatrice, il frigorifero e l’automobile.
Sono gli anni del boom economico e degli scontri generazionali.
Si stava meglio eppure Beppe avvertiva l’insofferenza dei giovani nascosta nei discorsi rabbiosi.
La avvertiva pur facendo, in effetti, fatica a comprenderla veramente.
Per capirla avrebbe dovuto vedere i debiti, le rate e gli strozzini nascosti abilmente dietro la facciata del benessere.
Un percorso lucido di riflessione viene proposto dall’autrice intorno a temi forti come la disoccupazione, l’abuso edilizio, la camorra soccorritrice del popolo affamato, gli appalti truccati, il contrabbando, la prostituzione.
Un percorso che non scarica la responsabilità del degrado in cui era caduta la città solo sulla malavita, ma è cosciente e obiettivo nell’ammettere che la fame e il desiderio di potere di molti sono state le reali e tangibili cause di una deriva verso la corruzione.
Poi la pandemia dell’asiatica, il mettersi nelle mani di Dio, le notizie che arrivavano filtrate, la preoccupazione, per sé, per i propri cari e per la città intera.
La sofferenza e la paura trascorrono in una manciata di pagine fino a quando, come Dio volle, l’asiatica smise di imperversare sugli umani e la vita riprese.
L’emancipazione femminile, faticosamente raggiunta, viene qui inserita nel contesto con molta cura. Spesso le donne sono state infatti nemiche di sé stesse, o semplicemente, le grandi rivoluzioni hanno bisogno di tempo e di molti passaggi prima di essere metabolizzate.
Passaggi tra le mani di uomini-polpo totalmente indifferenti ai titoli di studio.
Eppure non abbiamo mai smesso di provarci e non dovremmo mai smettere neanche di ringraziare queste donne degli anni cinquanta e sessanta che hanno con pazienza coltivato il seme della parità, dell’uguaglianza, dell’equità.
Donne, ragazze dai grandi valori che non si sono tirate indietro e hanno affiancato i colleghi maschi nelle contestazioni studentesche che hanno visto la Federico II in prima linea, in bilico tra un sistema al collasso e la spinta della neonata coscienza politica che circolava come sangue vivo tra la generazione degli anni settanta.
Quella stessa generazione a cui dobbiamo non l’origine ma sicuramente la consapevolezza della nostra identità.
Il linguaggio è specifico, quindi cari lettori non aspettatevi un saggio di letteratura italiana, ma il calore di una lingua che la Gionfriddo riesce a farci amare con molte sfumature di colore.
Se la lingua è musica questo romanzo è sicuramente un’allegra ballata.
In ultimo quell’amore mai sazio per i libri e quella consapevolezza che proprio a loro molti di noi sono debitori di libertà e indipendenza.
Consiglio per la lettura: da accompagnare con delle graffe napoletane per addolcire l’animo in tumulto.