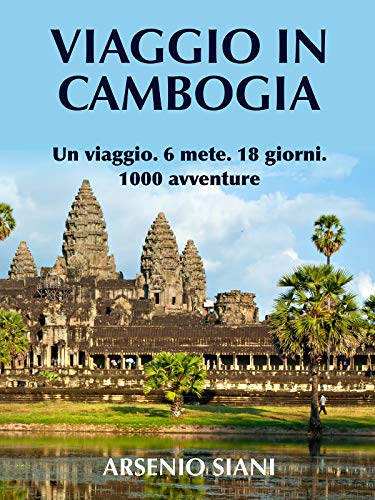Leggere un libro con lentezza esasperante affinché possa durare in eterno e non smette di diffondere la sua magia. E avere un puro terrore di essere abbandonata e quindi per evitare di lasciare quella voce amica, cercare di ascoltarla sempre più a lungo, leggendo e rileggendo le parti sottolineate, come un incantesimo affinché si stampi a fuoco dentro l’anima.
Ecco perché amo molto la lettura.
Anche se libri di questo genere non sono così tanti quanto si dovrebbe presupporre. Perché oggi si pensa più alla vendita che al puro talento. Si dimentica l’arte, quella che ti fa uscire da te stesso per abbracciare il cielo e dissetarsi con un sorso di infinito. Leggere è emozione, è immersione totale in un altrui mondo, è la fantasia senza briglie che corre come quei bellissimi cavalli servaggi delle pianure americane. Addomesticarli è un atto blasfemo, perché non si può addomesticare la libertà. È un dannato immondo ossimoro.
Poi, per fortuna, quando meno te lo aspetti e dove non spereresti mai, brillano parole che ti chiamano con voci suadenti come quelle delle sirene di Ulisse:
vieni da me
ti sussurrano;
devo raccontarti una storia.
Ed è una fiaba che ha il sapore della realtà, che è legata ad altre storie simili eppure diverse, tutte con il miglior protagonista del mondo: l’essere umano. E non umano nel senso carnale del termine, ma grondante di quegli attributi che lo rendono sia carne che spirito, sia forma che sostanza, che lo rendono vivo e vibrante.
È strano che quest’emozione sia stata scritta da uno dei miei miti giovanili, il leader di uno storico gruppo che ha alimentato tanti sogni, che ha inciso sulla nostra cultura musicale, che è e sarà sempre protagonista di un’Italia che riscopriva la sua capacità di creare. E creare musica quella vera, quella che rapisce e frusta il volto come un vento selvaggio.
ho già fatto le valigie
e adesso sto scrivendo
questa lettera per te
ma non so che cosa dire
è difficile spiegare
quel che anch’io non so capire
ma fra poco me ne andrò
e mai più ritornerò
io ti lascio sola
Ah! Quando s’alza il vento
Ah! Quando s’alza il vento
No! Più fermare non si può
dove vado non lo so
a me sembra di strappare
qualche cosa dentro me
e vorrei gridare no!
ma se guardo quella porta
io la vedo già aperta
ed ho voglia di fuggire
di lasciare dietro me
tutto quanto insieme a te
di partire solo
Quante volte ho ascoltato la stessa canzone, sentendo davvero il richiamo del vento?
Quella voglia di andare via, di non voltarsi indietro che sposa quel bisogno di muoversi, di non restare mai fermo in un punto, di non invecchiare osservando soltanto la vita che scorre da quell’angusta prospettiva.
I Dik Dik sono questo.
Non i cantanti trasgressivi, ma i poeti di quell’insana e assurda voglia di viaggiare, di cambiare continuamente scenario non fisico, ma psichico. Sono loro i veri ribelli. Non i finti maledetti, pieni di fissazioni e perversioni mostrate con disinibizione sul palco, ma che, in fondo, lasciano una sorta di amaro sapore in bocca. Perché la tua anima, quella veramente indocile, sa benissimo che è tutta una triste recita. È una bella maschera con cui il maledetto conformismo si camuffa attirandoti sempre di più tra le sue spire agghiaccianti.
No, loro erano i nuovi sognatori.
Quelli che cantavano la bellezza di essere sulla strada, incantati non dalla destinazione, ma dai mutati paesaggi che scorrevano veloci, lasciando sempre un segno, un insegnamento o soltanto un effluvio.
Ecco la possibilità di immergermi nel mondo altro, quello sempre più distante eppur vicino alla nostra istintualità, quello più primitivo, meno edulcorato dal politicamente corretto e forse per questo più affascinante per chi come me si sentiva sempre un’eterna esclusa: l’Amazzonia.
Conoscevo molto bene, attraverso racconti e libri, la sua cangiante bellezza, quei paesi abbarbicati al suo ecosistema minacciato, quelle popolazioni così aliene e diffidenti. Le sentivo profondamente unite a me da uno stesso filo. Io a Roma non respiro. A volte mi sento così soffocare da questa città ingombrante, tanto da dover aprire la finestra. Ho bisogno di trovare un albero, un fiore, un insetto. Ho bisogno persino di essere punta e di provare dolore, per reagire al pericolo dell’onnubilamento del mio io, quel pericolo che ogni mondo globalizzato, ogni democrazia che venera l’uguaglianza senza porre l’accento sulle singole potenzialità, ogni civiltà che non coopera ma assoggetta, pone.
Ecco cosa mi soffocava.
La mancanza di empatia, di veri legami, di essere parte sì, di un agglomerato, ma distinta e forse accettata per qualche mia bizzarra capacità, fosse anche quella di creare mondi e di sognare nuovi universi, fino a sentirli così tanto vicini da sfiorarli.
Amazzonia mi fermo qui ha questa straordinaria capacità di restituirmi aria pura. Di riuscire ad assaporare odori sconosciuti e al tempo stesso familiari, di ascoltare voci diverse dalla mia, ma cosi intense da rimbombare con grazia nelle mie orecchie e accendermi quel pensiero affaticato, quasi atrofizzato da una sorta di inedia. Vedere colori nuovi al posto di un grigiore stancante e sentire sulla mia pelle la pioggia fredda, scrosciante, una furia, una tempesta che al pari di quella mia interiore, spazza con brutalità ogni ostacolo, ma al tempo stesso si rivela utile e importante per mantenere rigogliosa la foresta. Quel viaggio intrapreso con Pietruccio è stato, in realtà, un viaggio in quelle emozioni che mi avevano insegnato a temere: la ribellione, la volontà di mettersi alla prova, di dimostrare che gli ostacoli, il dolore, le difficoltà fanno parte di quel ciclo immenso e duro e splendido chiamato vita. E rifiutare anche tutta la civiltà per spogliarsi di ogni orpello, immergersi nel fango e uscirne diversi, magari apprezzando cosa si ha. Ma capendo che in fondo, ogni comodità, ogni conquista, va amata, depurata dalle scorie, così come la nostra civiltà va contestata e rifondata. Ed è quello che accade all’autore.
Capisce che è solo per un bizzarro gioco del destino che è nato nella parte giusta del mondo, quella che, nonostante tutto, ci permette di esprimerci. Magari con fatica, magari senza essere capiti, magari svolgendo il ruolo utile di devianti, ma possiamo farlo. Possiamo lottare e scegliere sia di addormentarci vicino al nuovo iPhone, sia di prendere le nostre possibilità e regalarle al mondo. Che le nostre armi siano una chitarra, una penna, una danza, un pennello, ognuno di coloro che amano e creano l’arte, possono iniziare a vivere nel loro mondo, in modo RESPONSABILE. Ma per farlo dobbiamo confrontarci, dobbiamo scendere dal nostro personale piedistallo e incontrare l’altro, incontrare il nuovo, combattere la tendenza all’assuefazione.
Chiudere il libro è stato triste. Mi sono sentita quasi orfana senza la voce di Pietruccio a narrarmi le sue avventure a raccontarmi le sue riflessioni. È stato un po’ come salutare un amico, abbracciandolo forte e ringraziandolo del dono immenso che ti ha elargito con un sorriso pieno di luce.
Cosa mi ha regalato Pietruccio?
La capacità di pensare, di riflettere attentamente su parole scritte con un sangue distillato direttamente dal cuore. Nelle mie orecchie ora risuona a tutto volume una delle mie canzoni preferite, quella che sembra scritta per me, con quel lieve ritmo da antica e fragile ballata
Lasciò il suo paese all’età di vent’anni
con in tasca due soldi e niente più
aveva una donna che amava da anni
lasciò anche lei per qualcosa di più
Promise a se stesso di non ritornare
al vecchio paese della sua gioventù
dove nessuno voleva sognare i campi d’arare e niente di più
Cominciò così a fare il vagabondo
girando paesi e città
cercò la fortuna in quartieri del mondo
dimenticando la sua povertà
Un giorno in casa di un grande poeta
trovò dei ragazzi che parlavan di pace
di colpo capì che era quella la meta
che aveva raggiunto per esser felice
Ritornò così a fare il vagabondo
girando paesi e città
voleva portare l’amore nel mondo
ma pensò al paese di molti anni fa
Senza un soldo in tasca tornò ancora verso casa
aveva capito cosa conta di più
davanti alla sua porta c’era lei che lo aspettava
tutto come prima e non chiedeva di più
E in queste parole c’è il senso dell’avventura descritta in Amazzonia. Pietruccio non è solo l’avventuriero, l’esploratore, il pazzo che mette quasi a rischio se stesso e la sua incolumità. È l’anima stessa dei Dik Dik, completamente avvinti e intrinsecamente legati al tema del viaggio. Un viaggio che è ricerca interiore, il provare al mondo l’esistenza di un universo segreto, del luogo per eccellenza dell’anima, del Rio abajo il Rio (come racconterebbe la psicologa Clarissa Pinkola Estes), laddove tutto muore e rinasce, il sogno che crea la realtà come nei bellissimi miti aborigeni.
Nel libro c’è un vero tempo del sogno, ossia la capacità di uscire dalle proprie ristrette dimensioni e osare entrare in quelle proibite o ignorate, questa è arte e creazione, questo è il vero profondo significato del viaggio. È un osare varcare i ristretti confini come fece Gulliver, ignaro degli avvertimenti. È la scoperta di Colombo, ignaro delle fobie. È un osare rompere i tabù, quelli che servono per tenerci ancorati a un’unica realtà, impedendoci di sognare e appunto di creare. È la volontà di muoversi, di combattere la stasi, di combattere la forma che resta sempre immobile, sempre uguale e che va contro la nostra stessa essenza di esseri in balia di un’unica legge: l’evoluzione. Perché l’immobilismo è l’antitesi dell’arte, così come l’arte è la nemesi della morale. Ma al tempo stesso l’arte è etica. E Pietruccio non ci regala solo musica che fa da sottofondo a brani intensi e bellissimi come l’isola di Wight o Sognando la California, la sua arte si esprime con mirabolante bravura nel suo racconto facendo commuovere, facendoci arrabbiare, lottando con un’innocenza e una purezza abbagliante, contro i limiti del pensiero umano e i suoi stereotipi. È un pensiero che non si arrende di fronte alle brutture, che si interroga fino quasi a litigare con Dio, per fermarlo, farci a botte e dargli un nuovo nome. Perché siamo noi a creare Dio, non è Dio a creare noi.
E Pietruccio lo plasma accogliendo l’altro, abbracciandolo, dandogli la mano e entrando con rispetto e gratitudine nelle altrui culture semplicemente con la curiosità onesta di un bambino. E non per sfruttarli o per sentirsi migliore, ma per provare ancora compassione.
L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.
Anne Carson
Pietruccio torna diverso.
Torna con una consapevolezza matura di sé stesso e della nostra presunta civiltà superiore. Nulla è superiore alla vita e la vita si manifesterà sempre in mille diverse sfaccettature e avrà volti di sconosciuti che sono parte stessa di un universo interconnesso in cui tutti noi, indios, europei, africani, americani siamo dipendenti uno dall’altro, rendendo ogni nostra più misera azione pregna di conseguenze. Sta a noi decidere se creare paradisi o inferni in terra.
Un bellissimo proverbio indiano dice:
Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso.
Ecco il vero significato del viaggio di Pietruccio e di ogni nostro vagare. Non una semplice attività ludica, un passatempo di annoiati viziati, ma una soglia arcana attraverso la quale ritroviamo il nostro mondo simbolico, superando barriere, abbattendo con il machete dell’empatia i preconcetti, per tornare pienamente noi stessi.
E io come lui spero che questo libro possa realizzare un grande obiettivo:
A tutti i complici silenziosi dello status quo ho sempre opposto, a modo mio, la mia chitarra, le mie canzoni, il mio modo di stare al mondo, e vorrei che anche le storie dei miei viaggi servissero a questo, perché sono essenzialmente storie d’incontro, che è la vera arte della vita, come diceva Vinícius de Moraes.