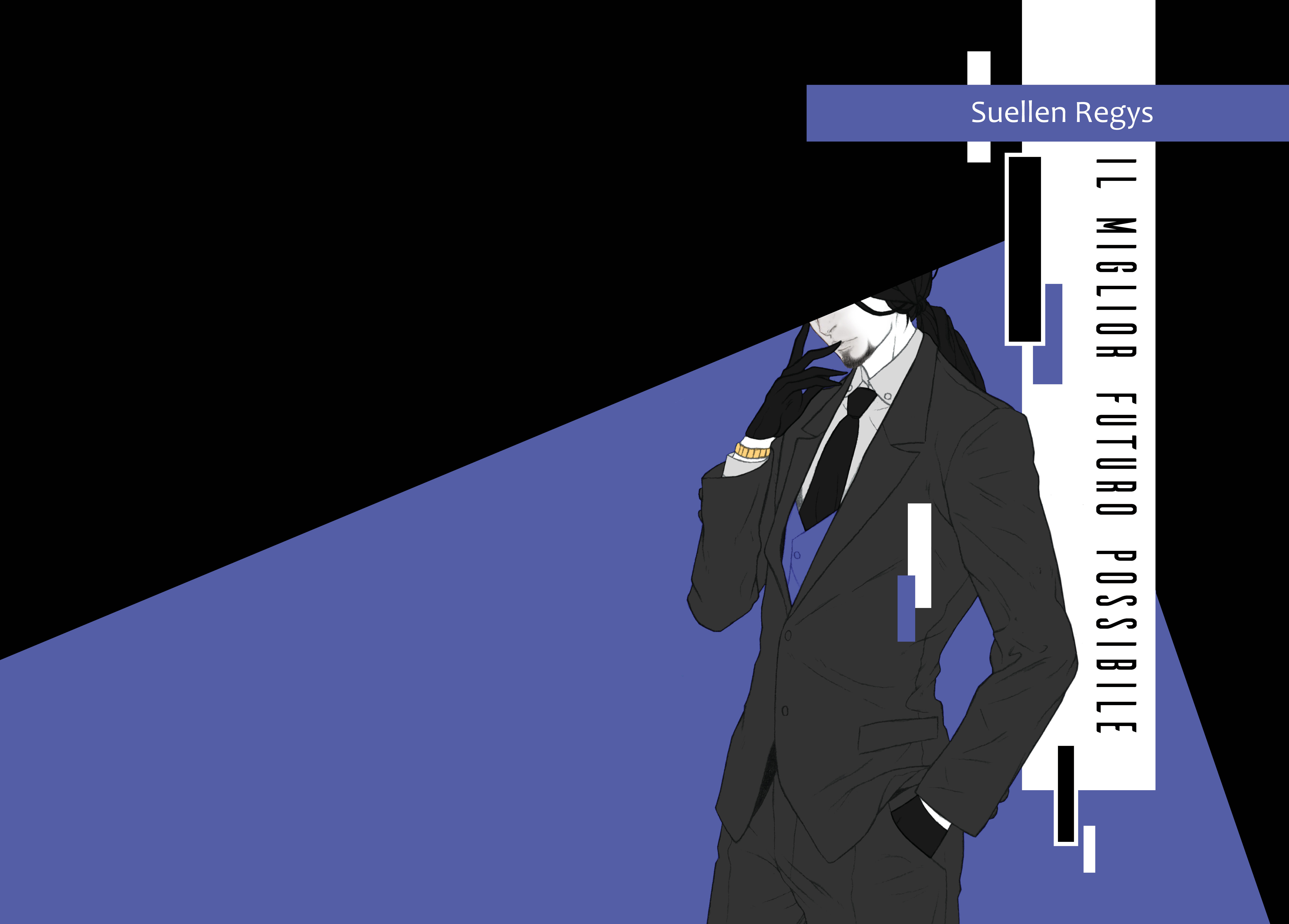Lo ammetto.
Sono letteralmente innamorata di Caspar Pestalozzi e di conseguenza provo una venerazione assoluta per il suo creatore, Claudio Vastano.
Le motivazioni di questa profonda ossessione per lo strampalato detective, risalgono agli anni della mia formazione letteraria quando, da ragazzina, divoravo tomi e tomi di gialli.
Ebbene sì, invece di aver coltivato sin da subito la passione per i saggi – quella venne in un periodo successivo, nei fecondi anni della mia formazione culturale giovanile – ero una divoratrice dei romanzi di Doyle (possiedo ancora una rara edizione de “Il segno dei quattro”), di Auguste Dupin – personaggio antesignano del famigerato Sherlock nato dall’oscura fantasia di Edgar Allan Poe – dei gialli di Agata Christie, di Simenon, di Rex Stout e di Chesterton.
Ognuno di questi grandi autori, perfetti a livello stilistico e strutturale, diedero vita a indimenticabili detective, come Padre Brown, Maigret, Nero Wolfe e ovviamente Miss Marple e Hercule Poirot. Personaggi geniali, dissacratori della società dell’epoca (basti ricordare come l’adorabile padre Brown fosse nato come mezzo per deridere il pensiero meccanicistico della Chiesa Anglicana) ma soprattutto dotati di sottile sapienza psicologica, conoscenza della natura umana e capacità deduttive fuori dal comune.
Eppure, lasciatemelo dire, nonostante il profondo amore per quella loro metodologia di indagine che anticiperà di anni la geniale idea di Carrisi sul dato che stona nello scenario rigidamente coerente dell’azione criminosa, erano…antipatici.
Sherlock era un pomposo snob, tronfio e pregno di idiosincrasie che sfioravano l’ossessione. Dupin un arrogante convinto, Maigret eccessivamente logico e tremendamente razionale, miss Marple una vecchia pettegola e impicciona, apparentemente adorabile ma irritante con quella sua finta aria da svampita signora di campagna.
E non parliamo di Poirot, odiato persino dalla sua mamma (in un saggio del 1945 la scrittrice si sperticò in lodi verso Sherlock ma definì il suo personaggio una persona noiosa).
Uomini simbolo di una giustizia che brilla, che mettono ordine in contesti disordinati, in un marasma moderno caratterizzato da patologie e devianza e che forse, dovevano assurgere a ruolo di educatori di una popolazione che rifuggisse il crimine, aborrendolo in virtù di un senso della bellezza, dell’armonia che andava dalla scienza pura, all’accettazione del ruolo sociale (Miss Marple) alla autoglorificazione del cervello rispetto alla banalità del male.
Lo stesso Poirot ci insegna:
L’omicidio è un’abitudine
che eleva i gusti dell’uomo superiore verso altre raffinatezze, altri piaceri estetici, come persino il cibo e il pensiero che, proprio in Poirot, raggiunge i massimi livelli.
Fantastico certo.
Ma sicuramente lasciava a me, comune mortale, un senso di vuoto, una sorta di disagio per la loro elevata statura morale che mai avrei potuto raggiungere.
Simboli di una giustizia che non poteva passare assolutamente dal mondo letterario a quello fisico, materiale, troppo preso a combattere contro una vita che seguiva le strade della sopravvivenza, del consumismo e della faciloneria culturale.
Pestalozzi è diverso.
Pur dotato di una notevole cultura, di un’intelligenza acuta e sviluppata al pari dei suoi predecessori, la manifesta con un’autenticità e una schiettezza assoluta, mantenendo il suo ego a un livello quasi inferiore, considerando il suo lavoro non tanto una missione ma quasi un obbligo etico, ingombrante, ma non per questo eseguito con minore serietà.
È in questo suo contatto con la quotidianità, con la vita che altri avrebbero catalogato come banale che Pestalozzi resta fondamentalmente puro, autentico, e rifugge quell’etichetta di superuomo che i suoi predecessori indossavano con prosopopea e alterigia.
Perché Pestalozzi, pur essendo a suo modo il genio più autentico perché calato nella realtà di ogni giorno, dotato di un acume mantenuto vivo e vibrante con il sarcasmo, con la capacità di sbeffeggiare ogni autorità considerata intoccabile, resta fondamentalmente ancorato al mondo quale unica e indiscussa palestra che consente al genio di essere, prima di tutto, uomo piuttosto che fenomeno da baraccone, da osservare con invidia, timore e perché no ammirazione.
Pestalozzi non è ammirato soltanto per il suo acume, perché in grado di risolvere casi intricati, restituendo la realtà a quei fenomeni che la cultura popolare relega come insoluti e misteriosi, ma perché è umano, perché non è il fantastico vincente di tanti racconti, perché vive la vita con quell’occhio scanzonato, perché nonostante viva momenti di pateticità assoluta, come tutti noi, riesce a risultare vincente.
In questo secondo capitolo Pestalozzi affronta un altro tabù intoccabile, quello non della scienza come progresso conoscitivo dell’uomo, ma della scienza al servizio del potere, del dio danaro, della finalità cosciente.
È quella scienza che non si bea soltanto nel porre domande e nel tentare di dare loro una risposta, ma si bea dei clamori della folla, dei riconoscimenti, si erige su un piedistallo tenendo lontano la realtà. Vittoriosa e totalmente slegata dai valori che, anzi, dovrebbero guidarla, cerca il consenso e la conferma del suo ruolo sociale e poco importa se questo può causare disturbo all’ambiente, se spezza vite o se non dona le acquisite competenza al mondo.
Il mondo è fuori dai luoghi della ricerca e gli esseri umani ma anche l’intero cosmo sono soltanto dei mezzi, delle tappe da superare per essere gli eletti, i deus ex machine, i dominatori indiscussi. In questo caso la conoscenza non è una tappa ma il punto finale per il completo dominio degli altri e della nostra terra, che ne risulta tremendamente danneggiata.
Si dissacrano i legami con l’ecosfera, si perpetuano orrendi crimini, sempre non nel nome della scienza ma in nome del nostro personale progresso.
In un mondo così rovinato, cosi patologico, Pestalozzi risulta un simbolo estremamente positivo, in balia di un assurdo che è in fondo molto meno assurdo della corsa insensata dell’uomo verso potere:
Avere un’autostima tanto insignificante non deve essere facile, in un mondo frenetico come il tuo.»
Eppure è proprio questo suo basso livello di ego a fargli comprendere una verità che è il fulcro di tutto il testo:
Già, utilità sociale.
Mi domando cosa ne sappia la nostra società di ciò che è utile e di ciò che non lo è. Vista quanta ricchezza consumiamo per il futile e quanto poco investiamo per l’indispensabile, direi che la lungimiranza non è proprio il nostro forte.
Con episodi esilaranti che sbeffeggiano in modo irriverente ogni autorità, persino quella di augusti tenenti convinti di agire in un telefilm:
l’ispettore con l’impermeabile alla Colombo è ormai troppo lanciato; Beretta alla mano, si spalma con la schiena a ridosso della parete del tunnel e inizia a strisciare verso l’oscurità. Ogni fruscio lo fa sobbalzare, ogni eco lo mette in allerta.
Giunto a una quindicina di metri dall’ingresso della grotta, si accorge di non scorgere più un tubo a causa del buio. Allora cosa fa? Estrae la torcia elettrica dalla tasca dell’impermeabile e proietta il fascio di luce verso la gola della miniera.
No, dico, ma cosa l’hai fatta a fare quest’entrata alla super poliziotto se poi ti fai luce con una torcia?
E troviamo il meraviglioso Trapasso che in barba degli studi psicologici ha capito che in fondo la morte è l’unico business possibile; abbiamo Laura e il suo apparentemente distorto modo di amare, che non ci allieta di poetiche elucubrazioni sul quel nobile sentimento, ma ci fa comprendere come, in fondo, quello che conti davvero è esserci:
Ma lo sa che quando Gustavo è tornato in paese, la sua fidanzata si è preoccupata tantissimo per lei?»
«Ah, sì?»
«Ha fatto tutto da sola, sa? Ha chiamato il suo strano amico sempre corrucciato e mio marito, e poi è voluta andare con loro a tutti i costi…
Anche se per certe faccende può sembrarle un tantino rozza, si vede che la sua fidanzata le vuole un gran bene.»
E poi abbiamo un altro indimenticabile personaggio, Gustavo che non potrete non adorare.
Chi è Gustavo?
Il vero protagonista del romanzo, un adorabile tasso che a parte il piccolo, insignificante problemino è davvero un amico fedele.
E quindi vi invito a ridere fino alle lacrime come ho fatto io, fino alle due di notte, facendomi osservare da un gatto allibito che non capisce come mai, ogni volta che leggo la Dunwich, o urlo in preda al panico, o rido a crepapelle.
Speriamo che l’ansia non mi crei mai l’effetto Gustavo.
Quale sia lo capirete solo leggendolo.
Pestalozzi forever!