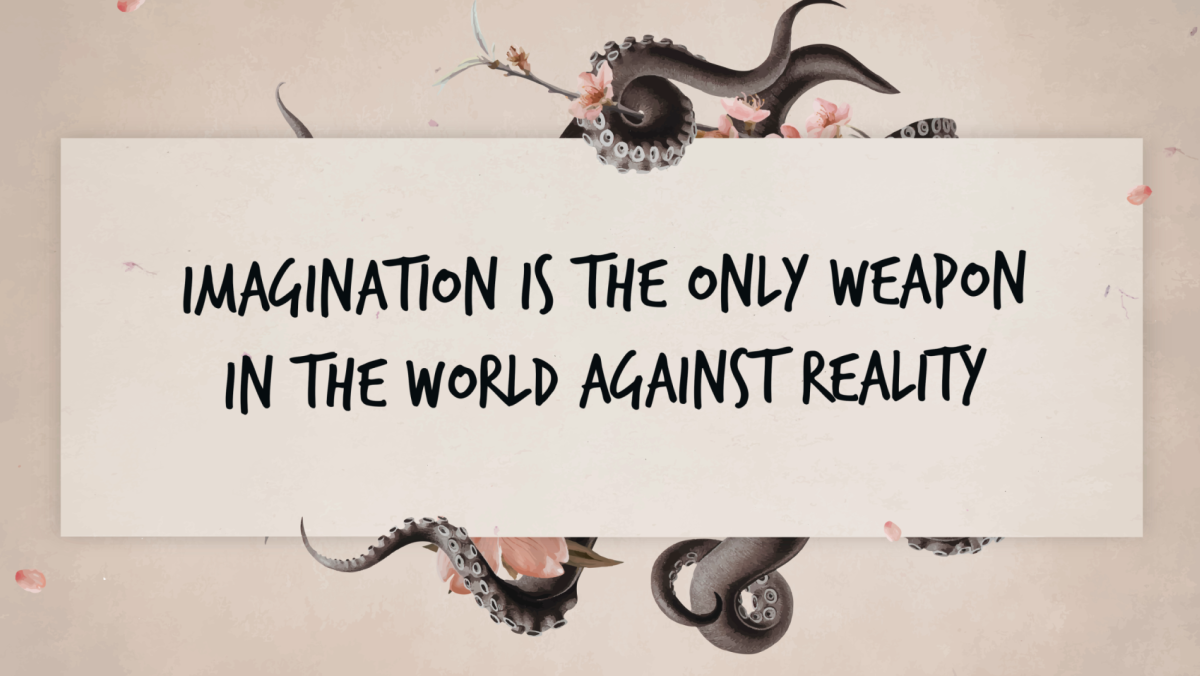Il contesto storico
Ai tempi in cui si svolge la vicenda che ho narrato nel romanzo “I Medici – Lorenzo il Magnifico”, (1469-1478) la penisola italica era ancora suddivisa in molteplici parti, tra ducati (come quello di Milano), regni (come quello di Napoli) e repubbliche (come quella di Firenze). Benché questi Stati (a cui si aggiungeva quello della Chiesa) attraversassero anche periodi di relativa quiete, la lotta tra loro per il predominio era costante, e ciò si manifestava anche nel micromondo fiorentino, dove invece degli Stati erano le famiglie a essere in eterna competizione. Tra queste, spiccavano la famiglia Medici e quella che si sarebbe rivelata la loro più spietata rivale, la famiglia Pazzi.
Fu in questo clima di tensione costante che emerse la figura del giovane Lorenzo de’ Medici. Dopo la morte del padre, Lorenzo divenne capo della banca della propria famiglia e, anche se in modo non ufficiale, signore assoluto di Firenze (nel caso dei Medici si parla infatti di governo occulto, o cripto-signoria, proprio perché nessuno dei membri della casata fu apertamente il capo dichiarato della città).
Come narratore (non solo storico) sono sempre stato attratto più dagli individui e dal loro “viaggio” personale che dai grandi movimenti politici e sociali. Per questo, romanzando la vicenda di Lorenzo, ho voluto raccontare, più che una storia corale, un intreccio di vicende umane, i cui percorsi hanno poi finito con l’incidere sul cammino della Storia con la “s” maiuscola. In particolare ciò che ho ricercato è stato il lato “straordinario” di questi personaggi, la forza concettuale che trasmettevano le loro vite.
Lorenzo de’ Medici
Lorenzo è senza dubbio il fulcro di tutto, il protagonista assoluto non solo del romanzo ma anche del Rinascimento, il perno attorno a cui ruota il destino della sua città e, di riflesso, quello della penisola e dell’Europa. Lorenzo esercitò infatti una politica improntata non alla competizione diretta ma alla diplomazia, cercando quanto più possibile la mediazione invece dello scontro, e fu per questo che venne definito “ago della bilancia” del suo tempo. Nel romanzo, la sua opera è in linea con l’eredità spirituale lasciatagli dal nonno Cosimo, un percorso che potremmo definire iniziatico in cui sono racchiusi degli obiettivi salvifici: attraverso l’arte e la riscoperta degli splendori dell’epoca classica Lorenzo vuole unire l’umano al divino, rendendo l’uomo davvero protagonista della bellezza del creato, restituendogli la libertà di essere padrone del proprio destino e della propria grandezza. Per riuscire a fare ciò deve però prima sedare ogni conflitto, deve creare l’equilibrio necessario a far sì che il genio umano possa esprimersi. In questo lo aiuta l’amore di due donne, alle quali è legato in modo diverso e di cui ho parlato ampiamente nella precedente tappa del blogtour: la sensuale Lucrezia Donati, di cui è l’amante, e la morigerata Clarice Orsini, a cui si lega in matrimonio per motivi politici. Ma ai tormenti di Lorenzo, ritrovatosi fin troppo giovane a doversi sobbarcare il peso di una simile missione (aveva vent’anni quando salì al potere), si sommano le difficoltà generate da rivali senza scrupoli, primo tra tutti Jacopo de’ Pazzi, intenzionato a mantenere il caos per poter ottenere i migliori vantaggi per sé e per la propria banca. Al fine di rendere il romanzo il più avvincente possibile mi sono approcciato agli aspetti più politici della vicenda narrandoli come fossero tappe di un viaggio avventuroso, prove che rendessero Lorenzo (e con lui i suoi comprimari) sempre più forte e pronto ad affrontare il cosiddetto show down della vicenda, il confronto finale, drammaticissimo, tra ciò che lui rappresenta (l’uomo nuovo, libero, padrone del proprio destino), e ciò che rappresentano i suoi nemici, in particolare Jacopo de’ Pazzi (l’uomo del passato, incasellato in una dimensione limitata e repressa, che esterna i propri rancori e i propri dolori nella ricerca del conflitto e della sopraffazione).
L’arte, la filosofia e i simboli segreti di Botticelli
Destreggiandosi tra agguati e intrighi, Lorenzo trova modo comunque di portare avanti la propria attività di mecenate, rappresentata nel romanzo soprattutto dal suo rapporto con la figura di Sandro Botticelli, uno dei più grandi maestri indiscussi della storia dell’arte. Sandro è per Lorenzo un amico, al pari di Poliziano e di altri illustri uomini di genio, e ne condivide gli ideali improntati alla filosofia neoplatonica, corrente di pensiero di epoca ellenistica che proprio i Medici, e Lorenzo in particolare, contribuirono a diffondere nel XV secolo. Nel romanzo vediamo Botticelli alle prese con un insolito “triangolo” insieme a Giuliano (fratello di Lorenzo) e a Simonetta Vespucci, l bellissima moglie del priore Marco Vespucci. Nei dipinti dell’artista, alcuni dei soggetti femminili hanno proprio il viso di Simonetta e la cosa interessante è che Botticelli, per indicare la bellezza della giovane come il tramite verso il divino, pare avesse nascosto in quegli stessi quadri alcuni simboli neoplatonici, individuati dagli studiosi solo in epoca recente. Si tratterebbe della riproduzione di polmoni umani, due nella “Primavera” (mimetizzati tra il fogliame), e uno nella “Nascita di Venere” (delineato dalle pieghe del mantello sorretto dalla dea Flora): i polmoni, per la dottrina neoplatonica, simboleggiavano il respiro divino che infonde la vita.
La conoscenza perduta degli antichi
Oltre alla narrazione delle vicende storiche, degli intrighi, del fiorire dell’arte e del susseguirsi delle avventure, ho voluto ricordare come l’opera di Lorenzo (la sua missione, potremmo dire) sia servita anche a riscoprire una serie di conoscenze scientifiche perdute. Mi riferisco in particolare alle tecnologie e alle macchine del passato classico che erano state dimenticate (o volutamente occultate?) nel corso dei cosiddetti “secoli bui”, e che diversi uomini di genio hanno contribuito a riscoprire e a reinventare proprio grazie all’appoggio dei Medici, che hanno fornito loro non solo il supporto economico, ma anche, pare, i manoscritti con le descrizioni di tali invenzioni arcaiche. Penso per esempio alle invenzioni di Ctesibio di Alessandria, vissuto nel III secolo a.C., che secondo Vitruvio aveva creato macchinari che funzionavano ad acqua e a pressione, oltre a veri e propri automi. In alcuni punti del romanzo, si vede come Lorenzo ricerchi ingegneri in grado di approcciarsi a queste tecnologie, ma nessuno di essi sembra in grado di comprendere e replicare le più complesse tra quelle invenzioni, tranne, forse, uno solo di loro…
Anche da questo tipo di ricerca scientifica emerge il carattere di Lorenzo così come l’ho voluto rappresentare: un individuo capace di valorizzare e sfruttare ogni aspetto del genio umano per costringere il mondo a ri-strutturarsi a misura d’uomo. E, nel romanzo come nella realtà storica, è proprio questo suo intento, questa sua vera e propria missione, a fare paura a chi vuole mantenere lo status quo, fino a spingere i suoi nemici a ordire una delle più sanguinose congiure mai attuate per cercare di fermare Lorenzo nel più drastico e spietato dei modi…