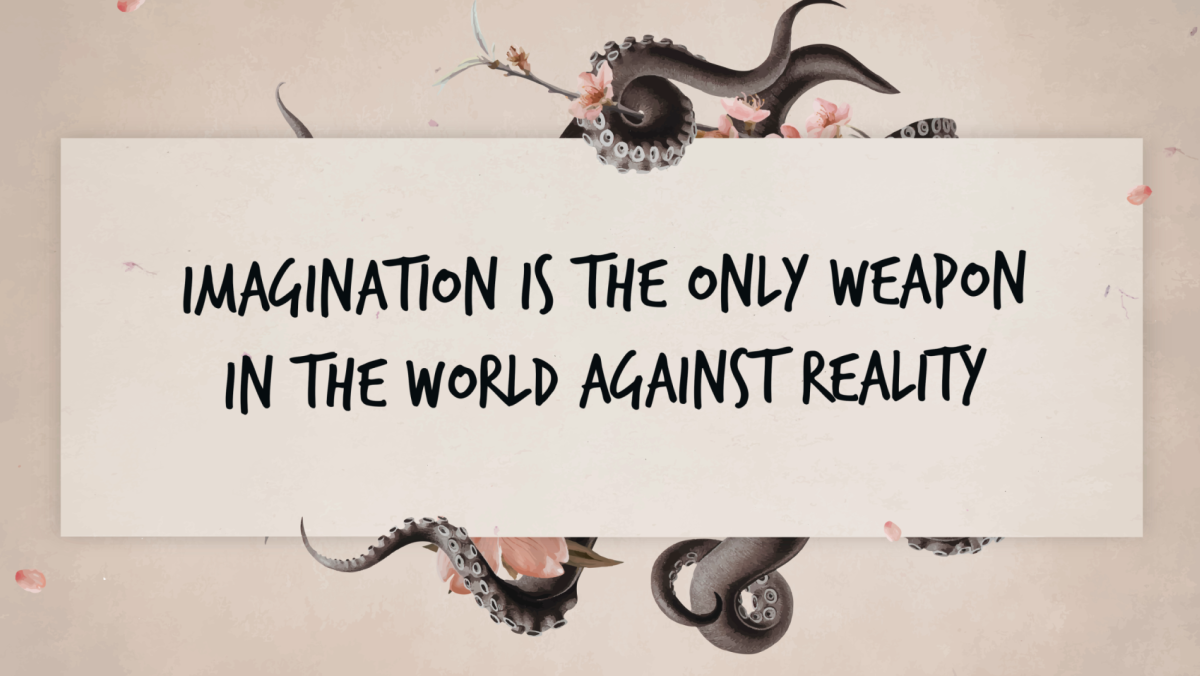La paura è da sempre stata uno dei sentimenti più controversi che l’uomo abbia mai provato.
E’ spesso considerata corrispondente a una mancanza di coraggio, una non volontà di correre i rischi.
Eppure, per alcuni psicologici la paura è molto di più ed è strettamente collegata alla sopravvivenza.
Dell’anima o della psiche.
Eh si cari lettori, il fatto di aver timore, terrore di qualcosa, è connesso con il nostro istinto di auto protezione, che ci consente di riconoscere le sfide pericolose quelle che possono mettere a repentaglio il nostro intero sistema biologico. Aver paura non è mancanza di coraggio, è la capacità di non sottovalutare le scelte e le responsabilità a esse conseguenti. E questo permette all’uomo di non compiere passi azzardati, di non scivolare verso bivi perigliosi, ma sopratutto ad avere quella coscienza in grado di farci redimere qualora la tentazione della via facile sia irresistibile.
Ecco che il lato oscuro, tanto esaltato da Jung, diviene terreno prolifico di elementi utili per la nostra evoluzione. Laddove si nascondo i demoni, si nasconde, per ironia della sorta anche la parte divina di noi. Perché il termine stesso di demone, come il termine sacro contiene in se una sorta di dualità: demone non è solo il terrificante maestro delle tenebre ma è anche il daimon, il genio sovrumano. Sacro significa tanto puro quanto impuro, in una scala cromatica che va dalla purezza assoluta alla blasfemia più abietta.
E chi decide quale identità debba prevalere?
Beh per dirla alla Silente le nostre, personali, spesso difficoltose scelte.
Siamo noi a creare il paradiso in terra, la poesia incarnata o la violenza più brutale.
Siamo noi a far emergere il senso di colpa salvifico e quello dannato che ci condanna, cioè, a una non vita, un’esistenza perduta.
Siamo noi, dunque, a avere streghe demoni, vampiri dentro di noi, cosi come possiamo avere fate, angeli, divinità benevole.
L’uomo è il contenitore in cui convive il terrore e la meraviglia.
Terribilis est locus iste, è un motto che si rivolge alla nostra interiorità, dove tutto esiste e tutto convive in perfetto equilibrio. O almeno dovrebbe, ma non sempre ci rendiamo conto che il dualismo una volta che si riconosce nelle sue differenti metà diventa monismo, diventa l’uno.
Ecco che le paura essendo connaturate con la psiche di questo strano animale uomo, evolve assieme alla sua mente. Avremmo paure peculiari per ogni epoca, e ogni epoca provocherà i suoi mostri. Se prima l’ignoto, il mondo considerato ostile aveva dato vita alle rappresentazioni di quest’avversità chiamata esistenza, oggi le nostre paure sono rivolte all’incapacità di trovare un equilibrio stabile tra il nuovo e la tradizione. Ci sentiamo minacciati dalla decadenza dei valori, incapaci di suggerire alternative valide. Ci sentiamo soffocati dall’aumento della tecnologia che spesso ci isola, in una privata bolla priva di veri stimoli sensoriali. Basta un click per avere tutto a portata di mano, senza uscire di casa e senza, quindi, affrontare non tanto le avversità della vita, quanto l’interazione con l’altro e la possibilità che da questa cadano gli ultimi vessilli delle nostre certezze. Sostituiamo le parole come empatia, compassione, solidarietà perdono, con vendetta, apparenza, successo, anaffettività, competitività parole che risuonano a vuoto, come campane a morto, in uno spirito inaridito privato di passione e di dolore.
Perché il dolore ci fa più paura di un vero demone cornuto, perché la perdita ci rende fragili e la fragilità non sappiamo gestirla.
Ecco che in questo Halloween che inaugura un’epoca apocalittica ( o almeno cosi la percepiamo) ma che invece è semplicemente tutta da riscrivere, ricca di semi e possibilità il progetto Parole inaugura un horror innovativo, che racconta senza pudori i veri terrori umani di oggi. E sono terrori che dobbiamo raccontare per scendere a patti e per far pace con le nostre lacune. Le streghe, le presenze che incontrerete in questo libro non sono più i ghignanti e spaventosi mostri di tanti altri horror. In loro si avverte la tristezza, la nostalgia per un tempo passato, in cui il simbolo ci aiutava a dare ordine e significato alla nostra vita. Perduti quelli tentiamo di trovare e di costruirci feticci, sostituti finendo per, per essere fagocitati da essi. Non è la strega reale protagonista del primo racconto di Emanuel D’Avalos. Lei non è altro che l’archetipo della disperazione, della fallace speranza di un uomo che, lungi dall’affrontare se stesso e i propri limiti, li sublima nella ricerca ossessiva del successo.
E non è forse, il dramma di noi tutti?
Quel non voler curare la ferita ma semplicemente coprirla fino a che essa non si infetti, con conseguenze spaventose.
Incontriamo anche, nell’arte di Dal Pont, l’incapacità di perdonare, di accettare la morte di trovare nell’orrore più osceno, una piccola speranza di redenzione. Di fronte a un mondo che con la violenza si impone, con la sottomissione dialoga, con quella assurda stevensoniana volontà di sostituirsi a dio, non riusciamo a reagire spezzando la catena di odio, ma semplicemente usando le stesse armi che ha usato l’aguzzino. Violenza con violenza, occhio per occhio, concetti resistono anche se svuotati di significato, in un mondo che chiede di essere compreso, che chiede a gran voce di essere definito in tutte le sue sfaccettature colorate, anche di tinte fosche, oramai stufo di essere relegato nello stantio binomio vittima carnefice, nemico amico.
E arriviamo all’orrore più claustrofobico definito dalla prefazione:
dalla frustrazione creativa dei metaforici Criceti di Emily Hunter
In questo racconto quello minacciato è il pensiero. Oggi come oggi esso viene talmente ingabbiato, talmente esautorato dall’informazione, bombardato da stimoli eccessivi privi della necessaria creatività atta a stimolarne le sinapsi. In parole povere, siamo in grado di sapere tutto e al tempo stesso nulla, siamo capaci di reperire informazioni senza il minimo sforzo e questo le priva della necessaria capacità del ricercatore, quella di farsi domande, di muoversi, metaforicamente parlando, di sforzarsi di cercare. Ecco perché la frustrazione creativa, tutto troppo, tutto eccessivo, tutto a portata di mano.
Abbiamo il senso di colpa in Apatia, laddove l’incapacità di elaborare gli eventi luttuosi, la perdita, rende la mente oramai morta. Il dolore non diviene porta ma muro, e questo muro che ci separa dalla realtà diviene cosi scivoloso, impossibile da scavalcare rendendoci preda del più nefasto destino. Eppure proprio vivere il dramma alla fine ci risveglia il cuore.
Loop invece racconta la difficile separazione tra realtà e sogno.
Dove finisce uno e inizia l’altro?
Cosa è reale e cosa no?
La realtà è stata definita da molti mistici come illusione, mentre per ironia della sorte è il sogno a essere la vera realtà. Ma una volta che i due piani vengono coscientemente uniti la mente è in preda alla più tragica delle situazioni che io definisco Overload emotivo.
E poi abbiamo uno dei drammi peggiori della nostra vita: l’ossessione della giovinezza. Consumata tra chirurghi e apparenza, tra osceni patti in cui di sacrifica la dignità l’uomo o la donna che fanno della bellezza un culto non sono altro che vampiri o morti viventi.
La tredicesima strega invece mescola le carte, e i buoni e i cattivi si inchinano scambiandosi i ruoli ed è al centro del dramma l’isteria religiosa che porta a considerare, come sempre, il sabato più importante dell’uomo.
E ancora l’uomo dentro la gabbia rosa, racconto strano, strambo, fatto di allegorie, laddove il ruolo centrale lo gioca la convenzione sociale, che va rispettata e osannata, il senso di repulsione verso la perdita del sè sociale, simboleggiata dalla possessione diabolica, un must ancor oggi presente
Ma la vera possessione è opera del diavolo o dai limiti imposti dalla società?
A voi la risposta
Troviamo ancora la vendetta, turpe figuro nella storia di Giuseppe Balsamo ( un nome che evoca le sulfuree atmosfere del suo omonimo) il desiderio di immortalità gabbato dall’impossibilità di superare le leggi divine. Abbiamo, insomma un campionario vasto di umanità allo sbando, alla deriva, incapace di essere pienamente se stessa, avvinta dalla vischiosità di un mondo che è incapace di conoscere e quindi incapace di ricreare.
Un mondo che è il vero demone, colui che fagocita la loro capacità di vivere appieno la bellezza.
Ma, in questo girotondo di terrori, la speranza non è affatto morta e la si ritrova nei due migliori racconti, per me simboli del vero Halloween, la festa che celebra la riunione del mondo spirituale con quello materiale e che apporta nuove energie nuova genialità al mondo.
Halloween lo ritroverete in Angeli un omaggio alla vera forza umana quella che:
«I veri Angeli siete voi che siete in grado di vivere in questo mondo.
Nonostante tutta la sofferenza che vi sobbarcate quotidianamente, riuscite a gioire delle piccole cose e delle opportunità che la vita vi offre.
Siete voi i veri Angeli.»
La ritrovate nell’amore costante e sacro, nel suo senso più puro di Fiori rossi, di Camilla Athena Restelli. Ed è quella fede nel sentimento, nella famiglia che impedisce all’orrore impersonato dalla guerra di uccidere davvero la redenzione. Essi gli uomini che sanno amare, che sono nutriti da questo sentimento non dall’odio, dalla rivalsa, dalla vendetta, dal rancore, torneranno sempre, per proteggerci o solo per regalare un fiore.
E allora Halloween ci insegna che in fondo, la morte è solo un passaggio. E la porta di questo passaggio la apre solo quel sentimento che:
che move il sole e l’altre stelle”
Io vi consiglio di immergervi nel ribrezzo, aspettando come premio succoso, una poesia che non ti aspetti, ma che ti avvolge l’anima