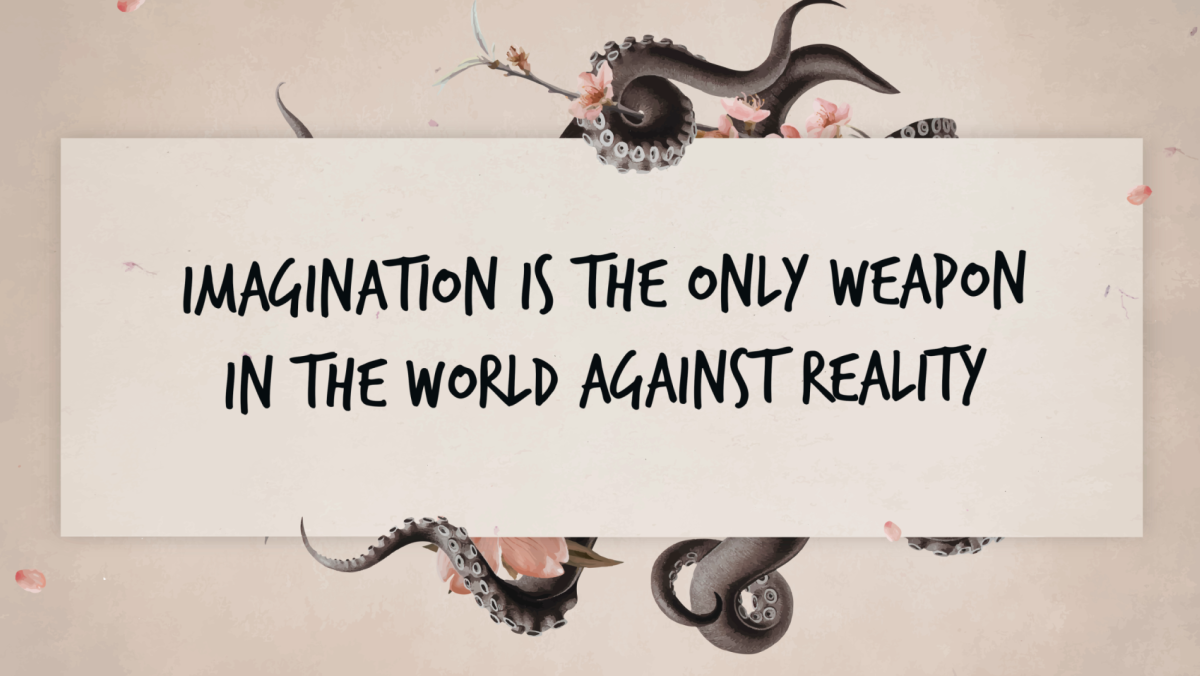Quando ho avuto tra le mani il libro, Io Cesare Borgia di Dario Pozzi, ero emozionata come una fanciulla.
E fanciulla purtroppo non sono più, ma per fortuna i libri mi portano indetto nel tempo affinché maturità e età infantile riescano a convivere. Ed è forse stato questo connubio ad avermi aiutato nella lettura del testo, liberandomi da aspettative e pregiudizi fino ad ottenere una candida anima pronta a emozionarsi, lasciarsi sedurre, stupire e perché no meravigliare.
A molti lettori manca questo senso della curiosità; troppo ancorati alle pallide certezze per poter essere sorpresi dal nuovo.
E, quindi, è stata una lettura assolutamente controversa, quasi avesse inciso dentro il suo DNA, il destino di seguire la dura sorte del suo protagonista amato o odiato, ma mai, per fortuna, ignorato.
Perché è nell’oblio del ricordo, nella damnatio memoriae che esiste il fallimento.
Perché il parlarne in modo positivo o negativo significa che qualcosa da dire esiste.
Ed è in quelle pieghe del sussurrato, del contraddittorio, del rabbioso diniego che si cela il vero portento di un testo.
In fondo, sono negli angoli sospesi tra due diversi finali o due diversi gradi di giudizio, che si celano invisibili agli occhi mortali, i mondi fantastici in cui mi addentro.
Felice e insaziabile e indiscreta.
Allora ho compreso che dalle critiche dovevo partire per farvi capire il fascino del testo, un fascino difficile da spiegare per chi come me non è avvezzo agli incanti letterari, quelli che ammaliano la mente e il cuore prima con la sonorità della parola, con la cantilena del ritmo e poi dopo all’improvviso con l’assolo indimenticabile, molto jazz, del significato.
Per chi non sperimenta il libro come un brano musicale da gustare, magari con un buon bourbon (ok lo ammetto io uso tè e limonate) è impossibile da far comprendere.
Allora andiamo a scoprire i segreti di Io Cesare Borgia e del suo geniale creatore, attraverso non le contestazioni, ma i residui logici di esse.
Cosa disturba tanto in un libro?
Anzi rettifico, cosa disturba in un libro storico?
Il primo dato è l’interpretazione.
Più di una volta mi sono trovata davanti commenti denigratori a volte, per libri che non eleggono a loro sommo sovrano il dato.
Eppure non è dal solo dato che si può ricavare la visione peculiare dell’ethos del tempo che fu.
Non tanto allora accadimenti precisi, vestiti, battaglie, armi e cibi, ma il significato di quegli elementi quotidiani, capace di contrassegnare il secolo trascorso.
Vedete la storia non è nelle azioni, date e città.
Non sono le dinastie, non sono le scoperte, non sono le guerre.
E’ tutto ciò che si insinua nei solchi di quegli avvenimenti.
Se immaginiamo la realtà non come un piano liscio e omogeneo, ma direi a stringhe ( perdonami Einstein se prendo a prestito le tue teorie) si capisce come in quei filamenti che si uniscono esistono dei luoghi, delle porte o ri-porte, in cui si ammassa il residuo logico di ogni azione.
Di ogni scenario e di ogni tempo.
Ed è in quel costume sociale, in quel folclore persino nelle superstizioni e nelle mitologie, ossia nel senso etnologico di ogni abitudine (alimentare o di vestiario che sia) che si conosce la storia.
Un esempio?
Basti pensare alla foggia modaiola totalmente differente che esibivano le dame al tempo di Jane Austen, ossia era napoleonica, che poi muta di colpo in una fastosa ma pesante guisa vittoriana.
In quegli abiti quasi eterei, leggiadri, non ingombranti ma qussi capaci di delineare maliziosamente le forme si celava l’assunto ribelle di un epoca. Al contrario, i vestiti pomposi, pesanti, quasi capaci di nascondere l’ardore femminile, nascondevano l’ansia morale della pruderie.
E quindi è impossibile separare, come molti fanno la piccola dalla grande storia, ma soprattutto è difficile dividere in conoscenza essoterica (ossia il dato logico, evidente e dimostrabile) dall’idea esoterica (ossia il dato nascosto, occulto, segreto da scoprire).
Del resto Balzac lo diceva sempre:
Esistono due storie: la storia ufficiale, menzognera…e la storia segreta,in cui si rinvengono le vere cause degli accadimenti. Una storia vergognosa”
Honorè De Balzac
Nel libro di Dario Pozzi, l’elemento mitico, quello apparentemente legato al solo universo della credenza vana, viene rivalutato e considerato l’elemento chiave o la pietra d’angolo che regge l’intera impalcatura del secolo analizzato.
Ed è nei valori, nelle filosofie, nei concetti che si agitano e si inseriscono tutti gli eventi che resero il Rinascimento e sopratutto la concezione del potere altamente particolari e unici.
Senza la convinzione, profonda tra l’altro, che la gestione della Res pubblica, del cittadino, dello stato non fosse supportato da una sorta di chiamata divina, non si potrebbero comprendere né intrighi, né atti di estrema brutalità, né persino la volontà forte e indomita di un uomo a sfidare i propri simili e addirittura il proprio tempo.
La coscienza di essere un Borgia, viene prima addirittura dell’uso reale del potere.
Prima si è illuminati da una sorta di sole divino poi, si diventa papi, principi e condottieri.
Ma soltanto con un valore cosi strano, cosi segreto, cosi per noi incomprensibile, si eleva l’uomo comune dalla massa.
Tutti i personaggi descritti non hanno solo una spiccata intelligenza ma la consapevolezza, ereditata dalla ricostruzione di un passato mitico, di essere pedine importanti sulla scacchiera del tempo.
Ogni famiglia e ogni dinastia ha la sua tradizione esoterica; è fonte e forza di ogni ardire, di ogni rivendicazione e di ogni atto estremo, finanche a sostituirsi alla divinità tradizionale.
Pensate la mito dell’origine Merovingia.
Sapete che si narra come essi discendano da una strana fata, donna serpente, una erta Melusina?
Anche il grande papa Silvestro II vanta una ricognizione nel mondo numinoso; stavolta a fare da tramite tra i due piani esistenziali è un altra torbida fata, Meridiana, forse una sorta di ibrido tra due lontane dee Mery e Diana.
Ed è un caso, forse, che i Borgia hanno come simbolo il toro?
Ed è un caso che esso sia l’animale totem di una divinità che nei secoli,si fusa con il cristianesimo?
E nel libro sono presenti in modo molto chiaro riferimenti a queste arcane tradizioni.
Che non cozzano assolutamente con l’idea che la storia sia una scienza. Solo che è una scienza sacra, poiché riguarda l’umano mortale.
A questa concezione esoterica e quindi riguardante anche gli aspetti psichici, filosofici della storia, si lega anche la venerazione per il dato oggettivo e non per l’interpretazione.
So che per molti amanti e scrittori del genere suddetto, il passato non è basato sul sentimento, o sulla percezione ma sul dato scientificamente oggettivo.
Pertanto la riscrittura in chiave moderna è vista come un onta o una blasfemia da punire.
Dati e solo dati.
Al che si può rispondere citando il sommo Pirandello, quando parla di falsificazione della narrazione.
Per quanto ci piaccia il dato incontrovertibile, ogni ontologia umana, persino la scientifica propriamente detta non è altro che, udite udite, una rappresentazione personale del nostro umile cervello.
Nessun libro può dirsi totalmente oggettivo.
Neanche il verismo, neanche lo storico, perché seppur parendo da un concetto fattuale, esso tramite il processo di creazione se ne discosta:
L’arte libera le cose, gli uomini e le loro azioni da queste contingenze senza valore, da questi particolari comuni, da questi volgari ostacoli, da queste accidentali miserie: in un certo senso, li astrae: cioè, rigetta, senza neppur badarvi, tutto ciò che contraria la concezione dell’artista e aggruppa invece tutto ciò che, in accordo con essa, le dà più forza e più ricchezza. Crea così un’opera che non è, come la natura, senz’ordine (almeno apparente) e irta di contraddizioni, ma quasi un piccolo mondo in cui tutti gli elementi si tendono a vicenda e a vicenda cooperano. In questo senso appunto l’artista idealizza. Non già che egli rappresenti tipi o dipinga idee: semplifica e concentra. L’idea che egli ha dei suoi personaggi, il sentimento che spira da essi evocano le immagini espressive, le aggruppano e le combinano. I particolari inutili spariscono; tutto ciò che è imposto dalla logica vivente del carattere è riunito, concentrato nell’unità d’un essere, diciamo così, meno reale e tuttavia più vero
Pirandello Saggi e interventi
Pertanto, è evidente che il narrare e qualsiasi tipo di narrazione e di genere, mettono in piedi un mondo ex novo, sia che si inventino nuovi mondi, sia che si rappresenti il più fedelmente possibile quelli già esistenti.
In entrambi si ottiene un qualcosa che è e deve essere altro rispetto alla realtà.
Per questo Dario Pozzi unisce a una perfetta conoscenza della storia uno stile che è poetico, sognante, a tratti onirico e assolutamente e deliziosamente (mi si permetta l’ardire) wildiano.
Ha la capacità di essere ridondante senza esserlo, poiché la sua scrittura è fluida e coerente, ma al tempo stesso dotata di un certo realismo magico, come solo l’arte pittoria può essere.
Ecco perché il suo storico sciocca gli sciocchi che seguono il dito e mai la luna.
Ecco perché, il suo tempo esula dalla storiografia classica che lo considera lineare, o al massimo circolare.
Un evento storico, infatti, secondo la visione classica segue un andamento di causa e effetto o un ordine cronologico rigido e intransigente.
Questo, però, se serve allo studioso per addentrarsi per la prima volta nella massa indistinta e a volte cacofonica dei dati, all’umano che dalla storia vuole imparare a capirsi e capire, suona alquanto arido e distante dall’esperienza umana.
Noi non siamo e non possiamo essere “lineari”.
Dotati di cosi tante sfumature seguiamo piuttosto un tempo a spirale, dove a ogni accadimento non segue una reazione precisa ma una serie di reazioni impostate sull’emotività.
A tal proposito non posso non citarvi (non me ne vogliate) Gianbattista Vico.
Che può essere utilissimo conoscere per potersi godere al meglio la genialità di Pozzi:
“Verum et factum reciprocantur seu convertuntur”, cioè il vero e il fatto si convertono l’uno nell’altro e coincidono.
La storia secondo la teoria dei corsi e ricorsi storici vichiani è un punto di incontro tra diverse discipline (filosofia, poetica, filologia, mitologia, antropologia) che si occupa di individuare e documentare non solo gli eventi, i fatti ma sopratutto li deve decodificare ricercandone quelle ragioni ideali ed eterne che sono destinate a
a presentarsi costantemente, in modo ripetitivo anche se in gradi diversi, all’interno di tutti i momenti della storia
Gianbattista Vico
I corsi e ricorsi storici presenti nel testo.
Ciò non significa che la storia si ripete.
Significa che è l’uomo a essere dotato di fattori specifici e seppur nel mutare delle situazioni e degli stravolgimenti è il suo apprendimento a proporre reazioni sempre costanti.
Il potere è il potere, la concezione di avere un dono o una missione si basa SEMPRE su concetti per nulla logici, ma oserei dire illogici e mitologici.
Ecco che nel testo questo concetto è perfettamente semplificato nel prediligere non la consequenzialità di un determinato agire ma, piuttosto, la spiegazione e la ricerca della sua genesi.
Ciò che emerge dal testo non è una successione di fatti, quanto piuttosto una cultura umana e personale straordinaria, creata dal fatto ( non è il dato, quindi che crea l’azione e la cultura ma il contrario) tanto da far apparire Cesare Borgia non come il cattivo di turno, (clichè banale che mal si adatta alla variabilità dell’umana memoria) ma come un uomo con una grande sete di vita, capace, come solo pochi sanno fare, di imporsi e di erigersi al di sopra delle consuetudini del suo tempo. Borgia in questo testo appare l’estraneo lungimirante che non accetta il ruolo che gli è stato riservato, per sangue, per famiglia, per capriccio, ma tenta di essere il demiurgo della sua ristretta dimensione temporale. Borgia tenta l’impossibile: andare oltre il tempo e divenire l’eternità fatta persona.
Per trovare il senso di avvenimenti particolare nella vicenda altrimenti orrendamente didascalica di Cesare, bisogna guardare al di la del fatto logico, cogliere dentro la sua personale storia un ‘altra invisibile, magari lontana nel tempo, magari in una Gerusalemme funestata dall’ansia di ribellione…
Pozzi risulta, dunque, avviso ai puristi del genere perché appunto grazie alla sua profonda conoscenza dei manuali si addentra nella storia eterna che è il vero segreto del passato, custodito e tenuto sotto chiave come una reliquia preziosa.
E in quest’ottica si colloca anche la scelta della cover.
Una cover che racconta l’esoterismo dei valori di Borgia, la sua aspirazione a elevarsi al di sopra anche dei dominanti del suo tempo per accostarsi a una lontana divinità guerriere…
Ma non vi svelo oltre.
Considero Dario Pozzi uno dei migliori e geniali e incredibili scrittori del nostro tempo perduto.
Unico in grado di trasportare il lettore attraverso i secoli visti non più come un ammasso granitico ma come:
la scala a doppia elica di Leonardo. Un infinito inseguirsi di due realtà che sanno di esistere, ma non si incontrano mai.
Dario Pozzi